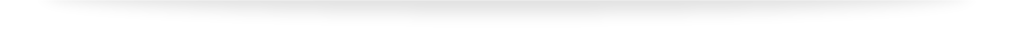Diciamoci la verità: di flat tax e reddito di cittadinanza conviene iniziare a dimenticarsene. Così come se ne stanno dimenticando tutti – protagonisti e commentatori – in queste schizofreniche settimane di corteggiamenti postelettorali.
E no, non solo perché il presidente dell’Inps ed economista Tito Boeri abbia calcolato che la proposta-vessillo del Movimento 5 Stelle costerebbe 35-38 miliardi di euro (dai 29 precedentemente stimati, in ogni caso una cospicua legge di bilancio solo per quel provvedimento). Quand’anche costasse quanto indicato dall’analisi Istat a cui i grillini fanno riferimento – 14,9 miliardi più 2,1 per riorganizzare i centri per l’impiego (auguri!) – si tratterebbe comunque di una manovra impressionante. Non basterà andare a Montecitorio in autobus per finanziarla.
Il problema è un altro, ed è tutto politico. Da una parte il continuo tira e molla fra Lega e 5 Stelle non promette nulla di buono. Buono per il Paese, s’intende. E se pure fosse in gran parte tattica che finirà in qualche modo per sciogliersi come con i presidenti delle camere – ma anche col forcing su vicepresidenti, questori e segretari, che hanno quasi del tutto estromesso il Pd dai vertici delle istituzioni parlamentari – una cosa sarebbe certa.
Né il reddito di cittadinanza né la flat tax rimarrebbero ciò che Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno venduto (con un certo successo) ai loro elettori.
Quei punti, come molti altri – come l’abolizione della legge Fornero già ribattezzata “revisione” – dovrebbero trasformarsi, cambiare nome e soprattutto mutare impegni finanziari: il Documento di economia e finanza, il programma economico dell’esecutivo che il Parlamento dovrà ricevere entro il 10 aprile, segnerà la strada della legge di bilancio autunnale ed è dietro l’angolo.
Semmai ci sarà un nuovo governo pronto a impostarlo, da quel provvedimento inizieranno a cascare i primi asini volanti. Ma per come sono messe ora le cose, è virtualmente impossibile che possa firmarlo un esecutivo nuovo di zecca. Se ne riparlerà con l’aggiornamento di settembre.
Il primo fattore è dunque pressoché logico: visto che nessuno ha la maggioranza, semmai l’impuntatura di Di Maio a fare il presidente del Consiglio dovesse cedere occorrerebbe comunque confrontarsi sui programmi. Ed è evidente, non fosse come banale leva di trattativa, che – quadro programmatico del Def a parte – a nessuno andrebbero bene i punti dell’altro così come sono formulati.
Dunque, semmai un esecutivo “politico” dovesse uscire dalle consultazioni in partenza martedì 4 aprile, non potrà avere nel programma flat tax al 15% in stile Lega o reddito di cittadinanza 5 Stelle style. Ovvio che quella roba, formalmente, rimarrà: ma sarà appunto ben diversa da com’era la mattina del 4 marzo.
Secondo elemento, il fiscal compact. Il patto di bilancio europeo approvato nel 2012 prevede diversi impegni per i Paesi che l’hanno sottoscritto. Due quelli essenziali: correre verso un deficit pubblico strutturale che non superi lo 0,5% del Pil, dunque verso un “obiettivo di bilancio a medio termine”, e l’obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del Prodotto interno lordo, come il nostro, di ridurre ogni anno di un ventesimo dell’eccedenza. “Non ci intrometteremo nel processo democratico, ma l’Italia deve rispettare le regole e abbassare il debito” ha spiegato Pierre Moscovici, commissario Ue agli Affari economici.
Diplomazia a parte, però, questo è il quadro: se l’Italia rompesse davvero il patto e superasse il 3% del rapporto deficit-Pil, magari per finanziare provvedimenti su cui il dibattito dovrebbe essere lungo e approfondito come quelli in questione, la rottura con l’Ue sarebbe inevitabile. Con conseguenze, procedure e sanzioni salatissime, che inoltre sconfesserebbero gli sforzi degli anni scorsi, quando – e questo è un altro elemento: gli impegni passati – le indicazioni dell’esecutivo prevedevano una riduzione del disavanzo pubblico dal 2,1 all’1,6% del Pil proprio per il 2018 sempre con le famigerate clausole di salvaguardia pronte a scattare se i conti non procedono nel verso giusto.
Davvero un governicchio Frankenstein – magari ampio nei numeri ma artificiale nelle politiche – si inoltrerebbe in un simile labirinto rompendo con l’Europa e lanciando una politica di bilancio fuori controllo? Difficile.
Ecco perché, come sta già accadendo in questi giorni, i toni si sfumeranno, le (impossibili) promesse scoloriranno e i fiori all’occhiello dei partiti cambieranno pelle per farsi spazio, riviste e profondamente corrette, fra le strette maglie consentite dalle finanze di un Paese sprecone e spendaccione.