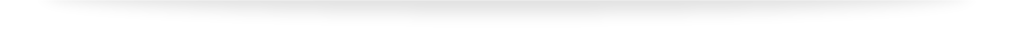L’esigenza di regolare lo svolgimento dell’attività lavorativa degli ex dipendenti, anche per il periodo successivo alla cessazione del contratto, è sentita particolarmente da parte di tutte quelle aziende che hanno sviluppato procedure aziendali specifiche rivolte ad una clientela selezionata. È ovvio che tale esigenza si manifesta soprattutto nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di alto livello che, per la posizione occupata, devono avere accesso a tutti quei dati, aziendali e commerciali, la cui diffusione arrecherebbe grave danno all’azienda.
Il legislatore, conseguentemente, ha previsto un particolare tipo di disciplina (c.d. patto di non concorrenza) al fine di limitare la facoltà del lavoratore di svolgere attività professionali in concorrenza con l’azienda nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Le relative disposizioni sono state trasfuse nell’art. 2125 c.c. che testualmente prevede: «il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo, di luogo». Tale accordo può trovare applicazione esclusivamente nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato (Cass., Sez. lav., n. 10403/2009).
Quindi, in sede di contrattazione possono essere definite, con l’apposizione di tale tipo di clausola (intesa quale estensione dell’obbligo di fedeltà vigente in costanza di rapporto ex art. 2105 c.c.), tutte le limitazioni che il dirigente dovrà rispettare in caso di cessazione del rapporto. Da rilevare che il patto non appare applicabile in caso di dimissioni del lavoratore (Cass., Sez. Lav., n. 11104/2007).
Il patto di non concorrenza soggiace a dei limiti ben precisi in relazione al periodo, al territorio e all’attività vietata; tutti elementi che devono essere obbligatoriamente ben individuati. La durata non può superare il limite di 5 anni per i dirigenti (mentre per gli altri lavoratori tale periodo è fissato in 3 anni); in caso contrario, tale limite viene ricondotto al massimo previsto ex lege. Il territorio su cui vige il patto può riguardare comuni, province, regioni ed, eccezionalmente, può anche superare tali limiti. Il principio generale, comunque, è che il patto sia da considerare nullo quando lo stesso sia così ampio (ad esempio per l’eccessiva genericità dell’attività vietata e/o per la grandezza del territorio di riferimento) da comprimere oltre misura ogni potenzialità reddituale del lavoratore.
Il patto di non concorrenza, quindi, si configura come un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore si obbliga a corrispondere denaro o altro tipo di utilità al lavoratore e questi, dal canto suo, si obbliga a non svolgere per il periodo di tempo previsto (e comunque entro i limiti temporali/spaziali suindicati) un’attività concorrenziale con quella del datore.
La legge non specifica l’entità minima del corrispettivo per il lavoratore. La giurisprudenza ha chiarito che, in ogni caso, il corrispettivo non deve essere simbolico, ma deve essere proporzionato al sacrificio sopportato dal lavoratore e determinato nel suo ammontare.
La violazione del patto da parte del lavoratore integra una ipotesi di concorrenza sleale, mentre l’azienda che lo assume può essere accusata di concorrenza parassitaria. In tali ipotesi, il datore può chiedere l’applicazione di una penale (di solito prevista nel contratto), e al giudice di ingiungere l’inibizione dell’attività lavorativa illegittimamente espletata.