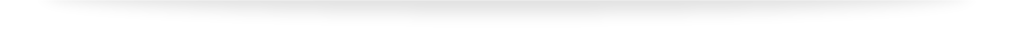Secondo un’analisi di Derossi e Galli, in Italia la figura del manager si è evoluta transitando per tre fasi storiche: la prima, in coincidenza con il boom economico e con lo stadio di massima espansione, si è arrestata negli anni della contestazione. In questa fase, di massima soddisfazione lavorativa, per il manager vi è anche la consapevolezza di appartenere ad un’élite all’interno della classe borghese che andava rafforzandosi.
Nella seconda fase, in coincidenza con la crisi economica e sociale degli anni ’70 che ha esacerbato i dibattiti interni alle fabbriche e fra gruppi sociali, il manager assume il ruolo di alter ego del “padrone” e subisce da una parte le pressioni delle spinte alla rivendicazione ispirate alla cultura di sinistra, dall’altra quelle dell’imprenditore che chiede a questa figura di operare contemporaneamente con criteri di razionalità e visione politica per mediare fra le parti.
Inizia così la consapevolezza da parte del manager di “essere in mezzo”: ne risulta svilita non solo l’immagine di onnipotenza ma soprattutto il commitment con l’organizzazione. Il manager si scopre asettico e professionale, focalizzato sugli obiettivi dell’azienda, che rimangono tuttavia estranei. Il mondo del lavoro, da luogo di investimento emotivo, diventa occasione di “mordi e fuggi”, dove la competitività è esasperata e il turnover un mezzo per stabilire rapporti di potere.
Tuttavia ciò ha esposto questa figura alle proprie debolezze: allo stress di dover costantemente assumere decisioni in un clima di incertezza e pressione esterna, si associa l’imprevedibilità dell’esito del proprio rapporto di lavoro che, non godendo delle protezioni riservate ad altre categorie, può risolversi in qualsiasi momento pregiudicando lo status economico e sociale raggiunto.
Questa analisi può apparire impietosa, ma è confermata dall’osservazione di molti indicatori, anche indiretti, come quelli riportati da una ricerca del CENSIS del 1987; in realtà – per quanto gli studi si concentrino prevalentemente in questo settore, intrecciandosi con altri relativi alla leadership, la motivazione al lavoro o tutti gli aspetti psicosociale del mondo economico e relazionale in ambiente lavorativo – quanto emerge è un po’ lo specchio dei processi in atto in tutto il tessuto sociale, in cui la persona appare ripiegata su modelli edonistici e bisogni individuali, prevaricando i legami di comunalità e protezione.
Le aziende faticano ad ottenere dai loro addetti, a qualsiasi livello operino, un livello ottimale di motivazione ed investimento sugli obiettivi ed il prodotto: ne risultano da una parte scarsa qualità dell’output e maggiori costi aziendali, dall’altra basso livello di benessere lavorativo e maggiore incertezza verso il futuro. L’ISFOL rileva che quasi il 60% dei lavoratori intende cambiare la propria occupazione poichè da questa non ha ricevuto conferme delle proprie aspettative di realizzazione e mobilità sociale.
I punti da cui osservare il fenomeno sono complessi: non va certo sotteso l’orientamento degli individui ad un miglior bilanciamento fra tempo di vita e tempo di lavoro che ha accomunato (più o meno volontariamente e consapevolmente) aziende e lavoratori nelle forme di contratti atipici, ma neanche l’incertezza che questo comporta.
Il tentativo di aggirare la rigidità del mercato del lavoro, soprattutto tramite modalità che non prevedono un rapporto indeterminato, ha creato una categoria di lavoratori che non conosce modelli di contratto psicologico basati su un forte investimento emotivo verso l’azienda e per i quali il lavoro ha centralità limitata nella vita, rispetto al passato, come hanno rilevato Novara e Serchielli. Dall’altra, a conferma di quanto rileva Vittorino Andreoli, la mancanza di orientamento al futuro, le aspettative negate, finiscono per veicolare modelli orientati al “qui e ora”, in cui gli individui non riescono a rappresentare gli esiti delle azioni e delle scelte che intraprendono, con esiti anche patologici.
In questo quadro a tinte grigie, una nota di colore viene dalla rinnovata attenzione da parte di vari organismi, dall’O.M.S. alla Comunità Economica Europea, fino ai centri di studio delle dinamiche psico-sociali, verso la responsabilità sociale delle aziende nei confronti della società. Ciò impone una visione in cui l’azienda non è un organismo avulso dall’ambiente ma al contrario una sub-cultura che si inserisce in un rapporto di reciprocità in una più ampia gerarchia.
La riflessione più attuale è pertanto: quanto il mondo produttivo subisce le difficoltà e i disagi che permeano il tessuto sociale e quanto contribuiscono a determinarli?