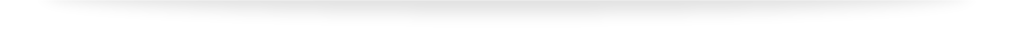In relazione al caso Wikileaks, un precedente che in questi giorni è stato citato da molti, compreso il direttore del New York Times Bill Keller, è quello di Daniel Ellsberg.
L’ex collaboratore del dipartimento della Difesa, nel 1971, consegnò al quotidiano della Grande Mela i “Pentagon Papers”, documenti top secret sulla guerra in Vietnam.
Ellsberg aveva partecipato insieme ad altri ad un lavoro di classificazione dei documenti sul Vietnam disposto dal segretario alla Difesa Robert McNamara, che doveva rimanere riservatissimo. Un lavoro imponente, raccolto in 47 volumi che contenevano 4mila documenti segreti e che dovevano essere letti al massimo da una dozzina di persone.
Ma leggendo quelle carte, Ellsberg fu evidentemente colto da una crisi di coscienza. Risultato: con l’aiuto di Anthony Russo li fotografò e li consegnò, appunto, al New York Times. Che li pubblicò sollevando un polverone (la Casa Bianca si rivolse a un tribunale che bloccò la pubblicazione, ma due settimane dopo fu la Corte Suprema a stabilire, invece, il via libera, facendo prevalere il primo emendamento sulle preoccupazioni dell’Esecutivo per la sicurezza dello stato).
Anche oggi il caso Wikileaks vede i giornali alle prese con la pubblicazione di documenti segreti o riservati e il governo americano infuriato (per la verità, l’arrabbiatura e l’imbarazzo hanno coinvolto gli esecutivi di mezzo pianeta). Il segretario di Stato Usa Hillary Clinton, riferendsi a Wikileaks, ha parlato di «attività criminale», «offensiva irresponsabile», e «attacco alla comunità internazionale».
Come è noto, i documenti in questione sono circa 250mila cablogrammi sull’attività della diplomazia a stelle e strisce, che riguardano i rapporti con alleati e paesi di mezzo mondo. In questi giorni sono in molti a chiedersi se e quanto le notizie diffuse siano effettivamente scottanti, quali effetti siano destinate ad avere, quale sia il valore del contenuto informativo. Tutte domande a cui la risposta arriverà con il tempo.
Ma ci sono elementi su cui l’accordo è generale. Sul principio che il lavoro dei media non è quello di difendere i potenti da eventuali imbarazzi hanno concordato, ad esempio, tutti i direttori dei cinque quotidiani che hanno ricevuto le carte (l’americano New York Times, l’inglese Guardian, il francese Le Monde, il tedesco Der Spiegel, lo spagnol El Pais). Così come tutti hanno evidentemente ritenuto che i documenti fossero interessanti, visto che li hanno pubblicati. Il direttore del Pais, Javier Moreno, ha spiegato chiaramente che a suo avviso la portata delle notizie era tale da giustificare, anzi obbligare, la pubblicazione. E sulla stessa linea si sono espressi un po’ tutti.
Contemporaneamente, però, tutti hanno anche sentito il bisogno di spiegare ai lettori il motivo per cui hanno ritenuto di pubblicare i dispacci, e in questi editoriali hanno preso in vari modi le distanze da Wikileaks, marcando le differenze con i metodi utilizzati dal sito di Assange.
«Trasparenza, analisi e giudizio non sono incompatibili e questo senza dubbio ci distingue dalla strategia di Wikileaks», scrive Le Monde. Il New York Times sottolinea di aver cancellato nomi e riferimenti a «persone che hanno parlato in modo riservato con i diplomatici e potrebbero essere in pericolo se fossero identificati», e spiega di aver contattato prima della pubblicazione il Dipartimento di Stato per registrarne le reazioni.
Come è naturale, il mondo si divide fra i difensori di Assange, che lo ritengono un paladino della libertà di informazione, e coloro che invece non lo amano per niente ed esprimono dubbi sulla buona fede del personaggio. Al di là delle opinioni di ognuno, il tema sollevato è enorme. E, più che la libertà di stampa e il rapporto fra quest’ultima e il potere, un tema che è sempre stato centrale, la questione vera sono i nuovi media. Come cambia l’informazione nell’era del web 2.0? Qual è il ruolo dei media? Quali sono i caratteri distintivi del giornalismo? La stampa sopravviverà alla rivoluzione digitale?
Domande al centro degli studi degli specialisti del settore che però si pongono anche i “normali” cittadini. Bill Keller propone una risposta citando Thomas Jefferson, che preferiva «giornali senza un governo, piuttosto che un governo senza giornali».